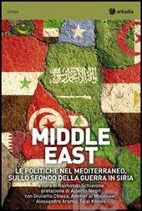22 ottobre 2008
Articolo originale: [QUI]

Questa settimana è stata pubblicata la classifica del Times sulle 200 migliori Università del mondo. L’unica Università italiana che compare nella lista è Bologna al 192 posto. Un dato negativo che dovrebbe far riflettere sui pericoli legati agli ultimi interventi del Governo in questo settore. E se si confrontano le scelte italiane con quelle di altri paesi (per esempio la Francia), la preoccupazione non può che aumentare.
Questa settimana è stato pubblicato il Times Higher Education-QS World University Rankings survey che fornisce una classifica delle prime 200 Università del mondo sulla base di dati relativi alla qualità della ricerca, al loro profilo internazionale e agli esiti nel mercato del lavoro degli studenti. In un articolo di commento alla classifica il Times si sorprende del fatto che tra le prime 100 migliori Università del mondo sia scomparso l’Ateneo di Bologna. A questo dato si può aggiungere che tra i primi 100 atenei non compare alcuna Università italiana. Le prime dieci università sono tutte statunitensi e britanniche. Ma nelle prime 100 compaiono anche atenei cinesi, irlandesi, svedesi, olandesi, coreani, francesi, svizzeri, australiani, belgi, russi, neozelandesi, tedeschi, canadesi, finlandesi, israeliani. In particolare, in questo gruppo le Università asiatiche sono ben 13. Scorrendo la classifica dal 101esimo posto al 200esimo troviamo il Messico, che piazza la sua migliore università al 150esimo posto e la Tailandia al 166esimo insieme a molti altri atenei presenti in nazioni a medio reddito.
Whatever happened to the University of Bologna?
E l’Italia? Bologna, unica università italiana presente tra le prime 200, è al 192esimo posto. Il fallimento dell’Università di Bologna ha colpito la fantasia del reporter inglese perché Bologna è stata la prima Università fondata nel mondo occidentale (nel 1158) e si era finora distinta nel mondo per la qualità dei suoi docenti e dei suoi corsi. La situazione dell'ateneo bolognese rispecchia perfettamente quella dell'Università italiana: un passato glorioso, un presente drammatico ed un futuro fosco a meno di interventi radicali. La nostra è proprio una Università (ed un paese) in declino.
Inutile ricordare come fa l’articolo che nel mondo attuale l’economia si basa sempre più sullo scambio di idee (brain power) più che di manufatti. Il mondo industrializzato ed i paesi in crescita hanno capito che bisogna essere attrezzati a capire e governare l’"economia della conoscenza" e che per fare questo la prima infrastruttura è costituita dalla presenza di buone Università. L’India, solo per fare un esempio tra i vari riportati nell’articolo, ha più laureati dell’intera europa ed il settore R&S indiano si è triplicato (non per magia, ma attuando i giusti interventi) in un decennio.
La politica italiana invece non l'ha ancora capito e presenta sempre una agenda in cui le priorità sono ben altre. L'attuale Governo ha appena varato una legge che taglia un miliardo e mezzo di euro per i prossimi tre anni e bloccato l’arrivo di nuovi giovani riceratori alla già impoverita e vecchia Università (su questo si veda anche un precedente articolo) senza alcuna misura che modifichi la disastrata governance del settore.
Questo taglio peggiora una situazione già seriamente pregiudicata. Se si considera la spesa per studente per l'istruzione terziaria in Italia e nei 13 paesi dell'area Euro, si scopre che nel 2001 quella italiana era pari al 91% di quella media dei 13 paesi, e che lo stesso indice era sceso al 77% nel 2005 (dati Eurostat).
L’articolo del quotidiano britannico si conclude invece con un invito a non cullarsi sugli allori (quello britannico risulta il secondo migliore al mondo) ed a sostenere ulteriormente il settore universitario nazionale. Questo, si dice, va considerato uno dei migliori investimenti che uno stato possa fare. Perché è chiaro che ormai “…the money will follow wherever the knowledge goes. And that is no longer to Bologna.”
Nel frattempo, in Francia...
Ancora qualche dubbio sul fatto che la risposta italiana alla crisi economica in atto è, in tema di istruzione universitaria, gravemente sbagliata e del tutto miope? Ecco un confronto tra le scelte francesi e quelle del nostro Governo. Un mondo di differenza di visione strategica, non a nostro vantaggio.
Italia ↓
Al comma 13 dell’art. 66 della legge italiana 133/2008 (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) si stabilisce che “…il fondo per il finanziamento ordinario delle università è ridotto di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013”. In 5 anni il finanziamento ordinario delle università viene ridotto per un totale di 1 miliardo e 441,5 milioni di euro.
Francia ↑
Lo scorso 26 settembre Valérie Pécresse, ministro dell’università del governo francese, in un comunicato stampa annuncia che “Le budget de l'Enseignement supérieur et de la Recherche constitue la première priorité budgétaire du Gouvernement, notamment avec un effort supplémentaire de 1,8 Md € en 2009, 2010 et 2011. Il traduit l'engagement de campagne du Président de la République de faire de la connaissance un pilier d'une croissance durable et du développement social. L'augmentation des moyens budgétaires et fiscaux sera de 6.5% en 2009 et de presque 17% sur la période 2009-2011.”
Traduzione aggiunta rispetto all'articolo originale:“Il budget degli studi superiori e della ricerca costituisce la prima priorità di bilancio del Governo, compreso uno sforzo supplementare di 1,8 mld € nel 2009-2010-2011. Riflette l'impegno elettorale del Presidente della Repubblica teso a fare della conoscenza un pilastro di una crescita duratura e dello sviluppo sociale. L'aumento delle risorse di bilancio e fiscali sarà del 6,5% nel 2009 e quasi del 17% lungo il periodo 2009-2001".

E’ già di per sé curioso scoprire che, mentre in Italia riteniamo che sia urgente ridurre i finanziamenti alle università pubbliche per garantire lo sviluppo economico, in Francia si ritenga esattamente l’opposto, è ancor più curioso scoprire che in un altro articolo della legge 133/2008 (art. 14) si preveda che “Per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.” Il totale è di 1 miliardo e 486 milioni di euro, quasi la stessa somma che si “risparmia” riducendo i finanziamenti all’università.
E’ ovvio che la coincidenza è puramente casuale, altrimenti in Italia avremmo trovato una ricetta molto originale per garantire lo sviluppo economico: - università, +Expo.
________________________________________________
* Breve nota metodologica. Il grafico confronta gli annunci ufficiali di programmazione su fondi universitari, in Italia e in Francia. Il dato francese si riferisce alla spesa generale per l’università; quello italiano si limita al fondo ordinario. In altre parole, in via di principio potrà succedere che interventi futuri su altre voci di spesa compensino in parte il gap con la Francia. Per ora niente di simile è stato annunciato da parte del governo italiano, e dubitiamo che ciò possa accadere in seguito. Benché dunque il grafico confronti i trend di due grandezze fra loro non perfettamente omogenee, esso offre indicazioni preziose sulle diverse scelte strategiche odierne dei due governi. Se poi l’Italia annuncerà nuove risorse capaci di compensare ciò che oggi appare un gap crescente, saremo ben lieti di aggiornare il grafico.