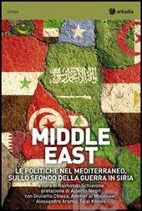Intervista di Enzo Pennetta a Fabio Mini.
Fabio Mini è uno dei più grandi
conoscitori delle questioni geopolitiche e militari, su Critica Scientifica
parla delle crisi attuali ma non solo. E dice cose molto importanti.
Gen. Mini, nel suo libro “La
guerra spiegata a…” afferma che non esistono guerre limitate, o meglio che
una potenza che si impegna in una guerra limitata ne prepara in realtà una
totale. Nell’attuale situazione di conflittualità diffusa, che sembra seguire
una specie di linea di faglia che va dall’Ucraina allo Yemen passando per Siria
e Iraq, dobbiamo quindi aspettarci lo scoppio di un conflitto totale?
La categoria delle guerre
limitate, trattata dallo stesso Clausewitz, intendeva comprendere i conflitti
dagli scopi limitati e quindi dalla limitazione degli strumenti e delle risorse
da impiegare. Doveva essere il minimo per conseguire con la guerra degli scopi
politici. E la guerra era una prosecuzione della politica. Erano comunque
evidenti i rischi che il conflitto potesse degenerare ed ampliarsi sia in
relazione alle reazioni dell’avversario sia in relazione agli appetiti bellici,
che vengono sempre mangiando. Con un’accorta gestione delle alleanze e delle
neutralità, un conflitto poteva essere limitato nella parte operativa e
comunque avere un significato politico più ampio. Oggi la guerra limitata non è
più possibile neppure in linea teorica: gli interessi politici ed economici di
ogni conflitto, anche il più remoto e insignificante, coinvolgono sia tutte le
maggiori potenze sia le tasche e le coscienze di tutti. La guerra è diventata
un illecito del diritto internazionale e non è più la prosecuzione della
politica, ma la sua negazione, il suo fallimento. Nonostante questo (o forse
proprio per questo) lo scopo di una guerra non basta più a giustificarla e chi
l’inizia, oltre a dimostrare insipienza politica, si assume la responsabilità
di un conflitto del quale non conosce i fini e la fine. Con l’introduzione del
controllo globale dei conflitti e della gestione della sicurezza (anche tramite
le Nazioni Unite), tutti gli Stati e tutti i governanti sono responsabili dei
conflitti. E tutti i conflitti sono globali se non proprio nell’intervento
militare, comunque nelle conseguenze economiche, sociali e morali. Quindi, a
cominciare dalla guerra fredda che i paesi baltici hanno iniziato contro la
Russia, dalla guerra “coperta” degli americani contro la stessa Russia, dai
pretesti russi contro l’Ucraina, alla Siria, allo Yemen e agli altri conflitti
cosiddetti minori o “a bassa intensità” tutto indica che non dobbiamo aspettare
un altro conflitto totale: ci siamo già dentro fino al collo. Quello che
succede in Asia con il Pivot
strategico sul Pacifico è forse il segno più evidente che la prospettiva di una
esplosione simile alla seconda guerra mondiale è più probabile in quel teatro.
Non tanto perché si stiano spostando portaerei e missili (cosa che avviene), ma
perché la preparazione di una guerra mondiale di quel tipo, anche con
l’inevitabile scontro nucleare, è ciò che si sta preparando. Non è detto che
avvenga in un tempo immediato, ma più la preparazione sarà lunga più le risorse
andranno alle armi e più le menti asiatiche e occidentali si orienteranno in
quel senso. E’ una tragedia annunciata, ma, del resto, abbiamo chiamato tale
guerra condotta per oltre cinquant’anni “guerra fredda” o “il periodo di pace
più lungo della storia moderna”. Dobbiamo quindi essere felici di questa “pace
annunciata”. O no?
Un’altra sua interessante considerazione riguarda il
fatto che la guerra porti sempre ad una politica diversa da quella che l’ha
preceduta e preparata, dobbiamo dunque prepararci ad un mondo diverso da quello
che sta generando i conflitti attuali? E se sì, ha idea della direzione in cui
ci stiamo muovendo?
Direi di si, ma non credo
che ci si possano fare molte illusioni sui risultati. Stiamo vivendo un periodo
di transizione storica molto importante: il sistema globale voluto dai
vincitori della seconda guerra mondiale sta scricchiolando, i blocchi sono
scomparsi, molti regimi politici voluti dalle potenze coloniali sono in crisi,
l’Africa si sta svegliando un giorno e regredendo il giorno successivo, le
istanze economiche hanno il sopravvento su quelle politiche, sociali e
militari, le periferie delle grandi potenze e i loro vassalli stanno cercando
indifferentemente o maggiore autonomia o una servitù ancora più rigida. I
conflitti attuali sono i segnali più evidenti di questo processo che porterà ad
una nuova formulazione dei rapporti e degli equilibri internazionali. Tuttavia
non è detto che questo passaggio porti al cosiddetto “nuovo ordine mondiale”.
Le spinte al cambiamento e alla stabilità sono ancora flebili e rischiano di
cronicizzare i conflitti e le situazioni, altrettanto pericolose, di post-conflitto
instabile. Ci sono segnali di forte resistenza al cambiamento in senso
multipolare da parte delle nazioni più ricche ed evolute come da parte di
quelle più povere. Quelle più ricche si stanno di nuovo orientando verso una
politica di potenza affidata soprattutto agli strumenti militari; quelle più
povere si stanno orientando verso la rassegnazione alla schiavitù. Il
cosiddetto “nuovo ordine” potrebbe essere quello vecchio del modello coloniale
e le forze armate si stanno sempre di più orientando verso il sistema degli
“eserciti di polizia” (constabulary
forces). In molti paesi dell’Africa si parla da tempo di “nostalgia” del
periodo coloniale o si accusano le potenze coloniali di averli abbandonati. La
potenza e la schiavitù sono complementari. Un filosofo cinese diceva del suo
popolo:“ci sono stati secoli in cui il
desiderio di essere schiavo è stato appagato e altri no”.
Venendo alla situazione italiana, se è vero che una
comunità che ospiti anche una sola base militare straniera è da considerarsi
“sotto occupazione”, la presenza di basi USA sul territorio nazionale ci rende
una nazione sotto occupazione o comunque non libera?
I regolamenti dell’Aja del
1907, stabiliscono i criteri dell’occupazione militare non tanto sulla presenza
militare in un paese ma nella sua funzione. Se una presenza militare anche
minuscola si assume la responsabilità della sicurezza del territorio (non
importa di quale estensione) in cui è stanziata, si ha l’occupazione “de
facto”. Le basi degli Usa non garantiscono la nostra sicurezza, ma la loro. Non
servono i nostri interessi ma i loro e quindi non sono legalmente “occupanti”.
Il fatto che si dichiarino basi Nato o facciano riferimento agli accordi di
Parigi del 1963 è una foglia di fico che nasconde la realtà: alcune basi
italiane sono aperte anche ai paesi Nato nell’ambito degli accordi
dell’Alleanza, ma le basi americane più grandi sono precedenti agli accordi
Nato e sono state concesse con accordi bilaterali in un periodo in cui l’Italia
non aveva alcuna forza di reclamare autonomia; anzi andava cercando qualcuno da
servire in America e in Europa. In queste basi decidono gli americani (e non la
Nato) a chi consentirne l’uso temporaneo. Si ha così un doppio paradosso: molti
italiani anche di alto lignaggio politico e militare tentano di giustificare le
basi con la funzione di sicurezza che svolgono a nostro favore. E avallano la
condizione di occupazione militare. Gli americani sono più espliciti, ma non
meno paradossali: ogni anno il Pentagono invia una relazione al Congresso nella
quale indica e traduce in termini monetari il contributo dei paesi ospitanti
delle basi “agli interessi e alla sicurezza degli Stati Uniti”. Dovrebbe essere
un accordo fra pari, ma si avalla la nostra condizione di tributari.
Nel suo libro ha mostrato come la guerra si sia
evoluta nel corso dei secoli, adesso siamo giunti a teorizzare una guerra di
quinta generazione o guerra senza limiti, una guerra cioè che non deve essere
percepita come tale e che coinvolge anche mezzi finanziari. Possiamo dire di
essere nel corso di una guerra di questo tipo?
Senza dubbio. Ma anche
questa quinta generazione sta trasformandosi nella sesta: la guerra per bande.
Non essendoci più soltanto fini di sicurezza e non soltanto attori statuali,
siamo nelle mani di “bande” con fini propri e senza alcuno scrupolo se non
quello verso la propria prosperità a danno di quella altrui. Le bande si
muovono senza limiti di confini e di mezzi, senza rispetto, solo all’insegna
del profitto. Tendono ad eludere il diritto internazionale e la legalità,
tendono a piegare gli stessi Stati ai loro interessi e a controllarne la
politica e le armi. Oggi il problema degli eserciti e degli apparati di polizia
non è quello di capire perché lavorano, ma per chi. Se lo Stato, per
definizione, deve (o dovrebbe) pensare al bene pubblico, la banda pensa
soltanto al bene privato, non statale e spesso contro lo stato. Quando nel 2004
chiesero ad un colonnello americano che tipo di guerra stesse combattendo in
Iraq, quello rispose candidamente: “è una guerra per bande e noi siamo la banda
più grossa”. Anche lui aveva capito che non stava lavorando per uno stato o un
bene pubblico ma per qualcosa che esulava dal suo stesso “status” di difensore
pubblico: era un mercenario, come tanti altri, al servizio di uno che pagava. E
per questo si riteneva un “professionista” delle armi. La finanza è l’unico
sistema veramente globale ed istantaneo e si avvale di mezzi leciti e illeciti:
esattamente come fa ogni moderna banda di criminali. La struttura di comando
delle bande ha due modelli di riferimento: il modello paternalistico e
verticale e il modello comiziale e orizzontale. Quest’ultimo sta prevalendo sul
primo anche se a certi livelli della gerarchia si ha comunque uno più forte
degli altri. Il modello orizzontale è anche quello che meglio riesce a
mascherare le guerre intestine e quelle esterne. Ci sono interessi contingenti
che spesso portano gli avversari dalla stessa parte.
Dal suo libro emerge anche il concetto di guerra come
“strumento d’imposizione”, cioè uno strumento per obbligare una determinata
parte a compiere azioni contro la propria volontà, nel recente caso della
Grecia in cui la volontà popolare ha dovuto cedere alle richieste di segno
opposto dell’Europa, possiamo parlare di un atto di guerra?
Anche in questo caso
dobbiamo riferirci alla guerra senza limiti e, purtroppo, a quella per bande.
La Grecia ha subito un’imposizione che piegando la volontà del governo e della
stessa popolazione è senz’altro un atto di guerra. Ma il vero scandalo della
Grecia non è nell’imposizione subita, ma nell’apparente lassismo in cui è stata
lasciata proprio dagli organismi internazionali che ne avrebbero dovuto
controllare lo stato finanziario. La guerra finanziaria alla Grecia è la guerra
per bande quasi perfetta. Solo qualche sprovveduto può pensare veramente che la
Grecia abbia alterato i propri bilanci senza che né Unione europea, né Banca
Centrale Europea, né Fondo Monetario, né Federal Reserve, né Banca Mondiale, né
le prosperose e saccenti agenzie di rating se ne accorgessero. È molto più
realistico pensare che al momento del passaggio all’Euro gli interessi politici
della stessa Europa prevalessero su quelli finanziari e che gli interessi
finanziari fossero quelli di far accumulare il massimo dei debiti a tutti i
paesi membri più fragili. Abbiamo la memoria molto corta, ma ben prima del 2001
il dibattito sull’euro escludeva che molti paesi della periferia europea e
quelli di futuro accesso (Europa settentrionale e orientale) potessero rispettare
i parametri imposti. Non è un caso se proprio i paesi della periferia siano
stati prima indotti a indebitarsi e poi a fallire, o ad essere “salvati” dalla
padella per essere gettati nella brace. Irlanda, Portogallo, Spagna, Italia e
Grecia sono stati gli esempi più evidenti di una manovra che non è stata né
condotta né favorita dagli Stati, ma gestita da istituzioni che si dicono
superstatali e comunque sono improntate al sistema privatistico degli interessi
del cosiddetto “mercato”.
La “narrativa”, la fiction,
gli spin doctors, giocano un ruolo
fondamentale nella guerra di nuova generazione, può indicarci qualche caso
concreto in cui ultimamente ha visto questi elementi in azione?
In ambito militare ogni
operazione è aperta, condotta e accompagnata dalla guerra dell’informazione e
da quella psicologica. Dal 2000 in poi in Afghanistan e Iraq furono disseminate
dall’alto migliaia di manifestini e radioline con le quali la coalizione
tentava di dare la propria versione del conflitto. L’aereo C-130 destinato alla
guerra d’informazione, chiamato “Commando Solo”, continua a sorvolare paesi
come Iran, Iraq, Afghanistan, Yemen e Siria trasmettendo giornali radio e
telegiornali dando la propria versione dei fatti. L’efficacia di tali mezzi
tecnologici è minata dal dilettantismo. I primi volantini in Afghanistan e Iraq
erano incomprensibili sia nella forma sia nella lingua. Le radioline furono
acquistate in fretta dopo aver notato che gli afghani erano immuni alle
trasmissioni radio visto che non avevano radio. E quando furono disseminate le
radio gli americani si accorsero che oltre il 90% degli afghani non capiva la
lingua usata. In Kosovo ho dovuto raddrizzare una campagna d’informazione,
condotta tramite materiale edito da Kfor, dopo aver constatato che una rivista
non veniva distribuita ai kosovari ma nelle caserme. In pratica si faceva
guerra psicologica sui nostri stessi soldati. Più professionali, ma meno
centrate sugli scopi militari, sono le trasmissioni radio della VOA (Voce dell’America)
che parla in molte lingue e perfino dialetti centro asiatici. La Russia è
entrata nel mondo della moderna guerra dell’informazione con nuove reti di
stampa, internet, radio e televisione. I cinesi hanno interi canali dedicati
all’informazione in varie lingue. Il programma Confucio, col quale s’insegna la
lingua cinese all’estero, è ormai presente in tutto il mondo. Gli spin doctors
del Pentagono avevano già immaginato nel 2011 come gestire la caduta di Bashar
Assad in Siria e uno studio cinematografico ne stava realizzando il film. Il
progetto è stato accantonato, ma il Pentagono spera che il film possa uscire
nel 2016 (a Bashar Assad piacendo). Lo scopo di queste iniziative è
difficilissimo perché la narrativa (la versione dei fatti) che si vuole fornire
dovrebbe contrastare quella dell’avversario e della gente del luogo. In realtà
nella comunicazione il messaggio più accettato è quello che conferma i fatti o
le percezioni e non quello che le contrasta. La narrativa dell’avversario pur
non avvalendosi di mezzi sofisticati e basandosi sulla trasmissione orale è
molto più efficace anche perché racconta quello che si vede o ciò che qualcuno
appartenente alla stessa comunità dice di aver visto. In Iraq, Afghanistan e
altrove non è stato infrequente il grido di allarme dei vertici delle
coalizioni occidentali: “stiamo perdendo la guerra della narrativa”. Fuori dal
contesto militare, la stessa crisi greca è un esempio attuale di guerra
dell’informazione accomunata alla guerra delle percezioni e alle operazioni
d’influenza. In Grecia, come altrove, l’eccesso di debito pubblico e
internazionale di uno stato non è di per sé un fattore fondamentale
d’instabilità né d’insolvenza. E’ invece importante la credibilità che può
ampliare a dismisura il credito. Per questo la guerra alla Grecia si è
sviluppata sul piano della guerra psicologica con un’azione forte di discredito
e di delegittimazione di tutto il paese. La delegittimazione che si è vista in
maniera palese nel caso greco, non è avvenuta per altri paesi in via di
fallimento, come il nostro; anzi, a dispetto dei dati oggettivi (debito,
crescita, disoccupazione, investimenti), ci sono paesi che beneficiano di
crediti oltre ogni ragionevole misura. Ogni volta che in Italia c’è un’asta di
titoli pubblici, i media plaudono al “collocamento” di tutto il pacchetto
sottacendo che in realtà si tratta di un aumento di debito. Anche il fatto che
il debito di tale tipo sia “interno” viene manipolato e sottovalutato
spacciandolo per una cosa senza valore. Come se il debito interno (quello nei
confronti degli italiani che hanno acquistato titoli pubblici) non dovesse mai
essere restituito ( e di fatto, così è), quasi che il rastrellamento costante
del risparmio privato da parte dello stato non penalizzasse la disponibilità di
denaro destinata agli investimenti produttivi. Oltre alle bande finanziarie
internazionali, in Grecia, come in Italia e altrove, ci sono bande
privatistiche interne che monopolizzano la finanza e la comunicazione. In
Grecia, come altrove, queste bande hanno sperato e tuttora sperano in un
ribaltone politico che le renda più potenti. E’ già successo, anche in maniera
violenta.
Pochi anni fa il fisico Emilio dei Giudice e il
giornalista Maurizio Torrealta parlarono di armi nucleari estremamente miniaturizzate,
di armi di nuova generazione che sarebbero state già impiegate sui campi di
battaglia in Iraq e in medio Oriente, e il cui uso sarebbe stato nascosto
dietro la radioattività dei proiettili all’uranio impoverito. Crede che
esistano elementi per ritenere fondata questa affermazione?
Non mi risultano casi
concreti, ma ho sentito le stesse storie in altri casi. Una caratteristica
delle guerre moderne è anche la perdita di consapevolezza sulla verità. Di
certo c’è che la moderna tecnologia, anche fuori dal campo sperimentale
consente questo ed altro. Se tali armi sono state veramente impiegate, si
tratta di una violazione del diritto internazionale e dei diritti umani delle
vittime. Purtroppo, ogni violazione (anche del buon senso, come nel caso della tortura)
è così frequente che non rappresenta più un ostacolo. C’è da sperare che lo
abbiano fatto gli americani: almeno tra trent’anni i segreti di stato saranno
derubricati e ci diranno la verità. Se le avessero usate i russi o altri paesi,
come il nostro, non lo sapremmo mai. Dovremmo aspettare che diventasse un
segreto di Pulcinella.
Critica Scientifica è un sito che si occupa molto
delle problematiche dell’informazione ed è noto che la prima vittima della
guerra è la verità, può dare ai nostri lettori un consiglio per difendersi e
cercare di distinguere tra realtà e manipolazione?
Abbiamo due armi
formidabili: diffidenza e ironia. La prima serve a neutralizzare il monopolio
dell’informazione. Significa cercare continuamente altre fonti e altri
riscontri senza bere tutte le scemenze ufficiali. La seconda tende a
ridimensionare anche quella che può sembrare la realtà. Perché la verità non è
più la vittima del primo colpo di fucile: non esiste più.